di Umberto Galimberti
La politica è una categoria antropologica, una dimensione
costitutiva dell'uomo, oppure un evento storico nato nell'antica Grecia e oggi
in via di estinzione? A porre in tutta la sua radicalità questa domanda è
Giacomo Marramao in Dopo il Leviatano. Individuo e comunità (Bollati
Boringhieri, pagg. 444, lire 60.000), dove i problemi del nostro tempo sono
irradiati dalle fìgure portanti e istitutive della cultura occidentale, di cui
in piena luce vengono le interne coerenze e le intime contraddizione.
La politica nasce in Grecia per effetto di quella sostantivizzazione
degli aggettivi per cui nascono le nozioni di "giusto", di
"bello", di "buono" e quindi anche di "politico",
che originariamente era un aggettivo che qualificava quella tecnica il cui
compito era di armonizzare le tecniche fra loro. A presiedere le singole
tecniche è infatti quella ragione, che oggi chiamiamo "strumentale",
per cui, per realizzare certi scopi, occorrono certi mezzi. Ma quali scopi
occorra realizzare è un problema che non riguarda la competenza delle singole
tecniche e perciò occorre quella "tecnica regia", come la chiama
Platone: "capace di far trionfare una giusta causa attraverso il
coordinamento e il governo delle tecniche" (Politico, 304 a).
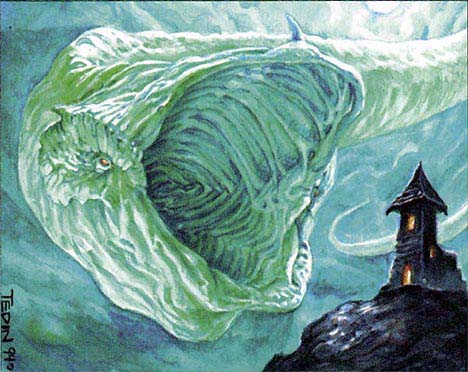 Modello ispiratore della politica è la natura che il greco pensa
come cosmo ordinato, in cui gli opposti trovano la loro composizione. Con
l'avvento del cristianesimo il modello non muta. Semplicemente l'ordine del
cosmo diventa l'ordine di Dio, e la politica si sottomette a quell'universalismo
non più cosmico ma teologico-morale, per cui indifferente diventa dire
"uomo" e dire "cristiano", come ancora vorrebbero il
cardinal Ratzinger, il cardinal Biffì e i loro seguaci.
Modello ispiratore della politica è la natura che il greco pensa
come cosmo ordinato, in cui gli opposti trovano la loro composizione. Con
l'avvento del cristianesimo il modello non muta. Semplicemente l'ordine del
cosmo diventa l'ordine di Dio, e la politica si sottomette a quell'universalismo
non più cosmico ma teologico-morale, per cui indifferente diventa dire
"uomo" e dire "cristiano", come ancora vorrebbero il
cardinal Ratzinger, il cardinal Biffì e i loro seguaci.
Con l'età moderna la natura muta volto e da cosmo ordinato, dove
gli opposti trovano la loro composizione, diventa laboratorio, sezione
dell'universo fisico ritagliabile per gli esperimenti. Analogamente la politica
cessa di essere quel governo deducibile dall'ordine del cosmo o dall'ordine di
Dio, per diventare con Hobbes contratto tra gli uomini pensati come individui
che, per ridurre i conflitti, delegano alla sovranità una parte della loro
libertà. La politica perde la sua fondazione "naturale" o
"teologica" Per diventare, come dice Machiavelli, uno status rei
publicae, uno "stato di fatto", da cui il nome
"Stato".
Da allora lo "stato politico" diventa espressione di quella
razionalità che deve difendere l'uomo da quello "stato di
natura" dove ciascuno è lupo nei confronti dell'altro uomo (homo homini
lupus) con conseguente danno collettivo. La legge che il politico emana non
si ispira più alla verità della natura,né alla verità di Dio, ma a
quella"tecnica neutrale" che ha in vista la neutralizzazione dei
conflitti. La subordinazione platonica della tecnica alla politica subisce un
capovolgimento, perché è la politica stessa a presentarsi con il volto
neutrale della tecnica. Ma la tecnica, sviluppando se stessa, deterritorializza
e sradica, togliendo alla politica quella sua dimensione tradizionale di tipo
spaziale che è il territorio. Non conoscendo confini al suo esercizio e
al suo sviluppo, la tecnica oltrepassa la nozione di "città" e di
"Stato", su cui la politica ha edificato se stessa, rendendo
inservibili le antiche mappe che, se non  aggiornate, più non servono a
riprodurre la nuova fisionomia del paesaggio.
aggiornate, più non servono a
riprodurre la nuova fisionomia del paesaggio.
Infatti, ora che il mondo è divenuto villaggio globale, ora che
l'Occidente ha esportato il proprio concetto mon-archico di politica dove
tutto e tutti sono guardati e visti solo sotto il profilo della quantità, le
differenze esplodono e grande si fa l'incomunicabilità tra il bianco e il nero,
tra l'occidentale e l'orientale, tra il popolo del Nord e il popolo del Sud che
la ragione unificante dell'Occidente fatica a conciliare.
Ma il mancato riconoscimento delle differenze non crea solo steccati di
incomunicabilità tra i popoli, ma, all'interno della stessa città, sempre più
cosmopolita, tra le differenti comunità. Qui l'Occidente, per il carattere mon-archico,
o come dice Marramao mono-teista della sua ragione e della sua
concezione della politica, è assolutamente impreparato, perché la differenza,
che un tempo incominciava ai confini della città e si risolveva con il trattato
o con la guerra, ora è all'interno della città, di ogni città divenuta un
concentrato di mondo.
La Rivoluzione francese aveva trovato uno strumento teorico per
affrontare questo problema, ma la storia successiva l'ha smarrito. Infatti,
delle tre parole inaugurate dalla rivoluzione: libertà, uguaglianza,
fraternità, le prime due hanno avuto successo perché, essendo compatibili
con la natura quantitativa della democrazia, hanno generato
rispettivamente la liberaldemocrazia e la socialdemocrazia. E della fraternità
che ne è stato? E che cosa davvero significa? Non c'è dizionario che ne renda
ragione, neppure il grande Dizionario della politica edito dalla Utet a
cura di Bobbio, Matteucci e Pasquino.
Il motivo è semplice. Si è fratelli per ragioni di sangue, perché
unica è la madre, unica la matrice, unica la psiche intima, profonda, tribale.
Sangue, madre, matrice, psiche, tribù non sono concetti razionali e, come
testimonianze di radicali differenze qualitative, mal si accordano con lo
stile della razionalità occidentale che conosce solo la dimensione della quantità.
Per questo la politica occidentale stenta a parlare con le differenze
culturali che un tempo incontrava ai propri confini e ora nelle proprie città.
Come sguardo puramente quantitativo la ragione occidentale e la politica che la
esprime faticano a riconoscere le
 differenze
qualitative, quindi le identità
specifiche, quindi le appartenenze, a cui invece risponde la nozione di
"fraternità", che garantisce il riconoscimento della comunità e,
attraverso la comunità, dell'individuo che alla comunità appartiene. La
democrazia come comunità quantitativa che misconosce, per esigenze di
razionalità, le differenze qualitative delle comunità potrà fare un
passo avanti solo recuperando e ricominciando a pensare quel concetto, dai
profondi sfondi irrazionali, che risponde al nome di "fraternità".
Allora, ma solo allora, potremo veder risorgere quegli dèi che, a sentir
Nietzsche, "morirono dal gran ridere quando udirono un dio che diceva di
essere il solo". Il riferimento non è tanto al dio ebraico-cristiano,
quanto e soprattutto allo stile mono-teista della ragione occidentale,
ben simboleggiata, in sede politica dal Leviatano, il mostro biblico che
Thomas Hobbes eleva a emblema dello Stato, il "Dio mortale", la
megamacchina statuale che ha segnato il destino della modernità in occidente.
differenze
qualitative, quindi le identità
specifiche, quindi le appartenenze, a cui invece risponde la nozione di
"fraternità", che garantisce il riconoscimento della comunità e,
attraverso la comunità, dell'individuo che alla comunità appartiene. La
democrazia come comunità quantitativa che misconosce, per esigenze di
razionalità, le differenze qualitative delle comunità potrà fare un
passo avanti solo recuperando e ricominciando a pensare quel concetto, dai
profondi sfondi irrazionali, che risponde al nome di "fraternità".
Allora, ma solo allora, potremo veder risorgere quegli dèi che, a sentir
Nietzsche, "morirono dal gran ridere quando udirono un dio che diceva di
essere il solo". Il riferimento non è tanto al dio ebraico-cristiano,
quanto e soprattutto allo stile mono-teista della ragione occidentale,
ben simboleggiata, in sede politica dal Leviatano, il mostro biblico che
Thomas Hobbes eleva a emblema dello Stato, il "Dio mortale", la
megamacchina statuale che ha segnato il destino della modernità in occidente.
Questo "gelido mostro", come lo chiamava Nietzsche, perché
menzoniero e insensibile alla varietà del divenire e della vita, oggi sembra
crollare sulle sue macerie, per effetto dell'avanzare del dominio della tecnica,
che che toglie al Leviatano il solido terreno su cui era edificato il suo
potere: il territorio. "Morte di Dio" e "Morte dello
Stato" sono per Marramao i tratti che caratterizzano l'epoca del "dopo
Leviatano" in cui si assiste alla pluralizzazione della politica a cui già
alludeva MaxWeber con la nozione di "pluralismo dei valori".
Il libro di Giacomo Marramao affronta con radicalità ed estrema
lucidità questi temi nel tentativo di segnalare con forza che la politica è
qualcosa di decisamente più drammatico e inquietante della miseria in cui
versa là dove si discute delle giravolte del "centro". La città
ormai è decentrata e le comunità che la popolano, chiuse in se stesse, non
hanno ancora trovato una piazza in cui diventa possibile incontrarsi. Ma
il futuro è in quest'incontro, dove il diritto di appartenenza (la fraternità)
possa conciliarsi con i diritti di uguaglianza e libertà. Qui la ragione
non basta. Abbiamo bisogno di una radicalizzazione del concetto di
"pace" che la politica occidentale, nonostante la pace al suo interno,
fatica ancora a reperire ai suoi confini.
Oggi ben pochi si dichiarano a favore della guerra, quasi nessuno
si proclama amante della guerra, ma tutti sembrano desiderare ciò che solo con
la guerra possono ottenere.
Quando a Bismarck chiesero se, allora, voleva la guerra, rispose:
"Ovviamente no, voglio la vittoria!". Molti capi politici vogliono lo
stabilirsi di una pace gravata da vergognose ingiustizie, preferendo entrare
nelle nazioni altrui a poco a poco, senza incontrare resistenza. Da questa
paradossale confusione dei valori, dalla loro deformazione e commercializzazione
prende avvio l'appassionato libro di Giuseppe Golsis che ha per titolo Eirene.
Lo spirito europeo e le sorgenti della pace (Gabrielli
Editori, avuto- via Cengia 67, San Pietro in Cariano (VR), pagg. 380, lire
48.000).
Il filone "barbaro" della modernità nata con il Leviatano di
Hobbes, sottolinea continuamente l'onnipotenza della guerra e, più in generale,
della violenza. "Con le baionette si può fare di tutto, tranne che
sedercisi sopra", dice il moralista cinico. Il bel libro di Goisis prova a
sfatare il mito del primato della guerra e della violenza, mostrandone le
connessioni con quell'Occidente che, dall'Iliade alla Guerra del Golfo,  da
Achille a Bush, ha affermato, con ossessiva coerenza, la decisività della forza
e, alla bilancia della forza, la decisività della propria potenza.
da
Achille a Bush, ha affermato, con ossessiva coerenza, la decisività della forza
e, alla bilancia della forza, la decisività della propria potenza.
A parere di Goisis, dall'Occidente si distingue il miglior spirito
europeo, giudicato ancora capace di percepire le grandi sfide storiche. Non
l'Europa soffocata dal costume mercantile, nella quale solo le scogliere di
Dover sembrano non ancora in vendita, ma l'Europa dell'umanesimo dell'altro uomo
e della convergenza nella diversità: la patria delle differenze. Di questo
miglior spirito europeo si invoca la ripresa, proprio nell'ora notturna nella
quale si manifesta il rischio di una grande "balcanizzazione", perfino
di una "balcanizzazione" della stessa cultura e dell'ideale di
razionalità che ha pervaso l'Europa. Di questa razionalità non c'è
più traccia secondo Alessandro Dal Lago che apre il numero 298 della rivista
AutAut dedicato a "La politica senza luogo", perché la
globalizzazione mina alle basi l'idea stessa di cittadinanza, facendo implodere
la funzione di rappresentanza politica. Con la globalizzazione, infatti, scrive
Dal Lago,. "il. potere non è soltanto plurale, ma ubiquo, introvabile, al
limite assente, e in quanto assente essenzialmente stupido. Parlare di
"stupidità" significa dire che le teorie tradizionali della
razionalità strategica (come quella weberiana, almeno in una versione
semplicistica) oggi sono semplicemente inutilizzabili".
Si considerino ad esempio le sanzioni contro l'Iraq con i loro effetti
letali su una popolazione civile già prostrata da vent'anni di conflitti. Chi
ne porta la responsabilità? L'apparato militare americano? La Nato che coopera
al mantenimento della supremazia militare occidentale? I produttori di armi e di
tecnologia militare? L'Opec o le multinazionali che producono e vendono a
qualsiasi titolo beni materiali e immateriali (dal software alle razioni di
campo) necessari alla continuazione della guerra aerea con conseguente genocidio
di fatto? Le imprese pubbliche e private che collaborano con le organizzazioni
politiche e militari? Trovare un luogo del potere responsabile del
genocidio iracheno è impresa impossibile. Così come è impossibile, a distanza
di un anno, individuare chi ha veramente deciso la guerra contro la Federazione
' jugoslava, quale potere l'ha autorizzata, quali vantaggi strategici e politici
se ne  volevano ricavare. Ecco "la politica senza luogo",
quella"dopo il Leviatano" dove gli Stati hanno ceduto la loro
sovranità economica, finanziaria e militare a entità trasnazionali che
nessuno ha eletto e le cui finalità sono in gran parte sconosciute, o
addirittura a poteri trasversali come le organizzazioni criminali
internazionali che, lungi dall'essere manifestazioni di mere
"barbarie", sono perfettamente integrate nel sistema del potere
mondiale in vaste aree del pianeta. Negli interstizi di questa "politica
senza luogo" tra i confini degli Stati flottano milioni di individui
che-con la loro stessa esistenza contestano l’idea di cittadinanza elaborata
dagli Stati occidentali negli ultimi tre secoli.
volevano ricavare. Ecco "la politica senza luogo",
quella"dopo il Leviatano" dove gli Stati hanno ceduto la loro
sovranità economica, finanziaria e militare a entità trasnazionali che
nessuno ha eletto e le cui finalità sono in gran parte sconosciute, o
addirittura a poteri trasversali come le organizzazioni criminali
internazionali che, lungi dall'essere manifestazioni di mere
"barbarie", sono perfettamente integrate nel sistema del potere
mondiale in vaste aree del pianeta. Negli interstizi di questa "politica
senza luogo" tra i confini degli Stati flottano milioni di individui
che-con la loro stessa esistenza contestano l’idea di cittadinanza elaborata
dagli Stati occidentali negli ultimi tre secoli.
La "turbolenza delle migrazioni" non sta, come pensano Haider,
Bossi e il cardinal Biffi, nella minaccia che i migranti costituirebbero per
l'assetto democratico e culturale delle società di immigrazione, ma, come
scrive Dal Lago, "nella pretesa concreta esercitata da milioni di persone
di sfuggire al destino assegnato loro nella divisione economica del lavoro
mondiale". Per cui è possibile dire che l'emigrazione rappresenta una
contestazione nei fatti dell'articolazione dei poteri degli Stati-nazione sul
territorio globale. Il terzo millennio si apre dunque con una politica senza
luogo perché deterritorializzata, e al tempo stesso onnipresente perché
indirettamente circola come denaro universale. Tutto ciò sfida la nostra
immaginazione. e la nostra ragione, obbligandoci a ridefinirci senza sosta e a
ricollocarci. "Dopo il Leviatano", questa è ormai la nostra storia.
