Hannah arendt
Hannah
Arendt ed Ernesto Grassi
parlano di Heidegger
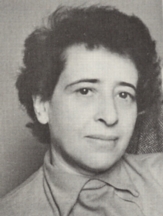
pensare senza parapetti
Vi
posto l'intervista a Ernesto Grassi che Giorgio ci
ha copiato nei commenti. Arendt
- Heidegger 60.
Martin Heidegger ad Hannah Arendt
Io sto leggendo l'epistolario tra Hannah Arendt e Martin Heidegger
che va dal 1925 alla morte di Hannah (Heidegger morirà pochi
mesi dopo), Edizioni Comunità, è un epistolario veramnte
bello e intelligente, sto vedendo il filosofo in una luce più
umana, mi riesce difficile vederlo come ci viene invece descritto di
solito, anche in questo articolo.
C'è qualcosa che non mi torna. Che Heidegger fosse nazionalista è
indiscutibile come indiscutibile è che si sia impelagato per dieci
mesi con il nazismo (forse anche dietro spinta della moglie).
Heidegger non è mai stato un un grande uomo coraggioso, però,
detto questo, è stato e rimane uno dei più grandi pensatori della
modernità, e forse incomincia ad essere veramente comprensibile
solo ora. Va quindi letto cercando di prendere il nucleo più
moderno, lasciandosi dietro la parte di pensiero
eventualmente legata al contingente, se lo ha fatto Hannah Arendt lo
possiamo fare anche noi. E ha ragione Sollers a dire che se
continuiamo a leggerlo come se fosse un nazista faremo
pochi passi avanti.
Heidegger ha fatto una operazione grandiosa, ha distrutto la
metafisica senza lasciare un vuoto al suo posto. Capisco che Grassi
non fosse del tutto in grado di apprezzare completamente la cosa
anche se, come tutti gli allievi, ne intuì ugualmente la
grandezza.
Scrive Hannah
Arendt a Martin Heidegger il 12 marzo 1970
mentre sta leggendo Tempo
ed Essere: «Sto continuando a rileggere Tempo
ed Essere, soprattutto il saggio su La fine della filosofia
e il compito del pensiero. Questa è naturalmente anche la fine
del positivismo e dei molti tentativi neo-positivistici. Già da
parecchi anni - da quando lessi l'Introduzione alla metafisica
- sono convinta che tu, con il tuo pensare-alla-fine della
metafisica e della filosofia, hai
creato veramente lo spazio per
il pensiero -senza parapetto1,
forse anche senza astrazioni, ma in libertà»
E nel 1968, per gli ottanta anni di Heidegger, aveva detto in un
discorso radiofonico registrato a New York il 25 settembre: «Forse
proprio lui [Platone] si è reso conto
del fatto che la dimora del pensatore, vista dall'esterno, somiglia
facilmente al mondo delle nuvole di Aristofane, In ogni caso sapeva
che il pensiero, quando vuole portare al mercato il suo pensato, è
incapace di difendersi dal riso degli altri; e può essere questo,
tra l'altro ad averlo spinto, già in età avanzata, a mettersi in
viaggio per tre volte alla volta della Sicilia, per andare in aiuto
del tiranno di Siracusa [...]. Tutti
sappiamo che anche Heidegger una volta ha ceduto alla tentazione di
cambiare la sua "dimora" e di "intervenire",
come allora si disse, nel mondo delle faccende umane: E per quanto
riguarda il mondo, gli è andata anche un po' peggio che a
Platone, perchè il tiranno e le sue vittime si trovavano non oltre
il mare, ma nel suo paese [...] Noi che vogliamo rendere onore ai
pensatori, anche se la nostra dimora si trova in mezzo al mondo,
difficilmente possiamo fare a meno di trovare sorprendente e forse
increscioso che Platone come Heidegger, la volta in cui si sono
impegnati nelle faccende umane, si siano rivolti a tiranni o a Führer.
Ciò potrebbe essere dovuto non soltanto alle circostanze del
momento, e ancor meno a un carattere già formato, ma piuttosto a
quella che i francesi chiamano dèformation professionelle.
Infatti l'inclinazione alla tirannide può essere dimostrata
teoricamente in quasi tutti i grandi pensatori (Kant rappresenta la
grande eccezione)».
Note:
1) Denken ohne Geländer (pensare senza
parapetti) è una bellissima massima arendtiana.
Caso Heidegger / Un retroscena italiano
Si
Stampi, disse il duce.
Intervista con Ernesto Grassi
di Maurizio
Bono
Quella sera di primavera, nella prima settimana di maggio del 1933,
di fronte all'università di Friburgo avanzava un carro tirato da
buoi. Sopra, ammassati alla rinfusa, più di mille volumi proibiti,
bottino del saccheggio nelle librerie della città. Di lì a pochi
minuti sarebbero finiti in un grande falò, passati di mano in mano
tra gli schiamazzi i "Sieg Heil" degli studenti nazisti,
entusiasticamente impegnati nella Kampfbund fur deutsche Kultur, la
battaglia a favore della cultura tedesca proclamata dal dottor
Goebbels. "Ricordo quell'autodafè come se fosse successo ieri.
E ricordo bene l'impassibilità indifferente di Martin Heidegger,
all'epoca rettore dell'ateneo friburghese".
l’abisso
della nostalgia
nella quarta dimensione della vicinanza

Hannah Arendt intorno al 1925

Hannah Arendt 1928
Meβkirch,
4 maggio 1950
ti saluto dalla “spiacevole distanza d tremila miglia”; il che ermeneuticamente
significa l’abisso della nostalgia. Eppure ogni giorno sono
felice che le cose siano così come sono. Ma molto spesso mi
piacerebbe passare il pettine a cinque denti tra i tuoi capelli
crespi, soprattutto quando la tua cara foto* mi guarda dritto al
cuore. Tu non sai che è lo stesso
sguardo che brillava rivolto a me sulla cattedra –ah, era, è e
rimane l’eternità, da lontano nella vicinanza. Tutto doveva
riposare per un quarto di secolo come un chicco di grano nel solco
profondo di un campo, riposare in una maturazione dell’assoluto;
perché tutto il dolore e le molteplici esperienza si sono raccolte
nel tuo stesso sguardo, la cui luce si riflette sul volto e fa
apparire la donna.
Nell’immagine della dea greca c’è questo di misterioso: nella
fanciulla è nascosta la donna, nella donna, la fanciulla. E il
peculiare è:questo stesso
occultarsi nel diradarsi . Questo è avvenuto nei giorni della Sonata
sonans1. Tutto ciò che è
precedente in ciò è stato salvaguardato.
Il 2 di marzo, quando sei tornata qui, è accaduto “il centro”,
che ha portato il già stato in ciò che dura. Il tempo si è
raccolto nella quarta dimensione della vicinanza, come se noi
dovessimo arrivare direttamente dall’eternità, e poi ritornarci.
Ti chiedevi se fosse realmente così: Oh, anche l’essere era
oltrepassato. Ma, mia intimissima amica, devi saperlo: “Pensosamente
e teneramente”2 – niente è
dimenticato, ma è proprio il contrario – tutto il tuo dolore
scarsamente considerato, e tutte le mie mancanze, senza volerle
dissimulare, risuonavano da un lungo scampanio della campana del
mondo dei nostri cuori. Risuonava nell’aurora, che, nei giorni
seguenti, ha fatto emergere per
noi quel periodo ora lontano dell’appartenenza. Tu –Hannah
–tu.
Tuo Martin.
Note
1)
Cfr. il successivo ciclo poetico Dalla
Sonata sonans, [che sono poesie di Heidegger dedicate e inviate
a Hannah Arendt e che sono riportate nell’epistolario, 61 e 63. n.
di georgia]
2) Pensosamente e
teneramente è il titolo di una delle poesie in Dalla
Sonata sonans.
In H. Arendt, M. Heidegger, Lettere
1925- 1975, Edizioni Comunità, Torino 2001, p. 71
Nota di georgia
*
la foto probabilmente è una di quelle di cui parla nella lettera
39 del 19 febbraio 1928 :”
”
(in H, Arendt, M.Heidegger, Lettere, cit.
pp. 44-45)
Essere
e tempo

«La
questione del tempo è essenziale. Se si continua
a impedire di leggere Heidegger trattandolo da nazista
non avremo fatto neanche un passo nella direzione del problema»
Philippe Sollers, intervistato da Marco
Dotti,
Dopo Tel Quel, in Il Manifesto, 3 luglio 2005, p.
12
Ultimamente
non si fa che parlare di Essere e tempo per via di alcune
nuove traduzioni e pubblicazioni.
Vi posto un articolo uscito ieri su La Repubblica e
approfitto per riportarvi anche una piccola curiosità che mi ha
colpito l'altro giorno, leggendo l'epistolario dell'egoista e cinico
Heidegger e della sua geniale allieva e amante Hannah Arendt.
Una lettera della moglie di Heidegger a Hannh Arendt, del 1969, in
cui le chiede di aiutarli per cercare un compratore per il
manoscritto originale di Essere e tempo.
Potete vedere QUI
un video tedesco su Martin Heidegger (io purtroppo non so
il tedesco) (georgia)
Scrive Elfride Heidegger (moglie di Martin) ad
Hannah Arendt, 20 aprile 1969.
Cara Hannah
Oggi sono io a scriverti per chiederti un favore: dopo una terribile
influenza ci siamo recentemente decisi a lasciare la nostra grande
casa a due piani e costruire, su un pezzo del nostro giardino
retrostante, una piccola abitazione su un piano solo, con una uscita
al pian terreno verso il giardino. Essa verrebbe a costare circa
80.000- 100.000 marchi, che noi naturalmente non abbiamo. Ma abbiamo
cose di valore. Martin mi ha appena mostrato il manoscritto originale
di Essere e tempo. Dato che però non capiamo nulla di
denaro, non abbiamo la pù pallida idea del possibile valore di
questo manoscritto, nè tantomeno sappiamo a chi lo si potrebbe
eventualmente offrire per venderlo. Glenn e Ursula Gray, con cui ne
abbiamo parlato ieri pensavano di rivolgersi a te; ma
preferisco farlo io stessa con questa lettera. Ti prego di trattare
tutta la faccenda con la massima discrezione: Ti saremmo grati di
una risposta veloce.
Per il resto adesso stiamo di nuovo bene, come spero anche tu e tuo
marito.
Ti salutiamo affettuosamente.
Elfride
Martin
Martin aggiunge:
si può mettere in vendita anche il manoscritto dei corsi su
Nietzsche
In H.Arendt, M.Heidegger, Lettere 1995-1975,
Edizioni di Comunità, Torino 2001, pp. 131-132.
A
trent'anni dalla sua morte escono due edizioni di "Essere e
tempo"
IL
SECOLO DI HEIDEGGER
Come
leggere oggi un'opera che mette l'uomo davanti alla sua desolazione.
Il suo capolavoro uscì nel 1927 e fu come se la filosofia mutasse
segno.
Provò a riconsegnare il pensiero alla sua originale grandezza che
la metafisica aveva oscurato.
Gli orrori che abbiamo vissuto nel '900, a cominciare dal nazismo,
sono qui anticipati.
di ANTONIO
GNOLI
La domanda è semplice, diretta, se volete, perfino ingenua: perché
Martin Heidegger ha avuto e continua ad avere successo? La parola
successo può trarre in inganno. Rinvia alla moda con cui spesso si
insegue un autore, lo si difende, lo si ama, ci si immedesima in
lui, ci si cala nel sue movenze linguistiche. Il successo di
Heidegger ci sembra nascere sotto un segno diverso, un segno così
forte e marcato da aver neutralizzato l´ampia schiera di detrattori
che nel suo pensiero ha percepito soltanto una fumosa e astrusa
costruzione filosofica.
In realtà, pensare oscuramente non sempre significa non pensare
affatto. A volte gli attriti concettuali, i problemi linguistici che
ci si ergono di fronte, gli enigmi nei quali ci imbattiamo non sono
il suono di parole vuote, ma rimandano a una difficoltà più
generale che riguarda il modo in cui la filosofia può ancora
affrontare il problema della verità. Heidegger non era diverso da
tutti i grandi filosofi che lo hanno preceduto. Anche lui si è
calato nel problema dei problemi: come dire la verità? Come
trovarla? Come trasmetterla?
A trent´anni dalla morte e a quasi ottanta dalla pubblicazione di Essere
e tempo, si continua a discutere di lui e della sua filosofia.
Lo si fa, crediamo, non perché si continua a subire stancamente la
sua influenza stregonesca (la quale in ogni caso ha un posto non
irrilevante a giudicare dal fascino indiscusso che ha esercitato sui
suoi allievi), ma in quanto Heidegger è il luogo concettuale in cui
il Novecento diviene qualcosa di paradossale e, starei per dire, di
unico.
A rilanciarne l´attenzione vi è la recente doppia edizione di Essere
e tempo, a detta di quasi tutti, compresi gli avversari, il suo
capolavoro filosofico. L´opera uscì nel 1927 con una dedica al suo
maestro Edmund Husserl. Dettaglio non irrilevante: nella quinta
edizione del 1941 la dedica verrà cassata. I detrattori videro
nella scelta di cancellare l´omaggio al maestro ebreo, il segno
eloquente della codardia di Heidegger. Il quale si difese osservando
che era quello il solo modo di ristampare l´opera. Questione annosa
e furente quella del nazismo di Heidegger. Vedremo se c´è un modo
per dirimerla.
In Italia Essere e tempo uscirà nel 1953 per i Fratelli
Bocca in una edizione curata da Pietro Chiodi. Personaggio
straordinario, partigiano, un po´ marxista e un po´
esistenzialista, Chiodi che era un professore di liceo di Alba,
rielaborò la sua traduzione che apparve in una nuova edizione,
prima nel 1969 per la Utet e poi nel 1970 per Longanesi. A distanza
di 35 anni Longanesi ripropone una nuova edizione di Essere e
tempo (pagg. 632, euro 28), a cura di Franco Volpi; e Mondadori
a sua volta pubblica un Meridiano (pagg. 1.550, euro 49) che oltre
ad avvalersi di una nuova traduzione fatta da Alfredo Marini,
comprende il testo tedesco a fronte.
Potremo dire che
delle due edizioni la prima è conservativa, nel senso che conserva
e adegua in parte il linguaggio usato da Chiodi (che è poi quello
invalso nel dibattito su Heidegger); la seconda è innovativa: si
distacca da Chiodi, e ne modifica a volte radicalmente la
terminologia. Entrambe le edizioni si avvalgono di un glossario. Più
esplicativo il lessico di Volpi, più rispettoso, al limite del
collage, quello di Marini. Il quale, oltre a un breve introduzione
in cui esamina la struttura dell´opera, offre un lunga postfazione
su cosa ha significato tradurre Sein und zeit. Il saggio è
alto e interessante, ma qualche sforbiciata gli avrebbe giovato.
Essere e tempo si articola in due parti, cui avrebbe dovuto
fare seguito una terza mai realmente realizzata da Heidegger. Alcuni
interpreti hanno visto in questa incompiutezza il fallimento
speculativo di Heidegger. Altri hanno parlato di "svolta",
intendendo con ciò che i problemi posti dal capolavoro del ´27
potevano trovare una soluzione fuori dall´orizzonte linguistico
delimitato dal libro stesso. Più precisamente in un Heidegger, come
del resto lui stesso auspicava, che andasse oltre l´analitica
esistenziale. Ecco il punto, la parola magica da cui partire, per
capire che cosa egli ci consegna con la sua opera tardo giovanile.
Il
lettore che non si lasciasse respingere al primo assalto troverebbe
in quest´opera qualcosa di sistematicamente selvaggio: c´è un´attenzione
spasmodica ai fatti, al mondo degli enti, e c´è un modo di dirli
che si avvale di un linguaggio in parte almeno radicalmente nuovo.
Heidegger, che ha 38 anni, ha letto e studiato tutto. In Essere
e tempo si rifonde la filosofia greca, quella presocratica,
platonica, aristotelica. Ci sono San Paolo, Tommaso e Agostino (nel
linguaggio heideggeriano serpeggia sovente quello teologico), c´è
la logica medievale. C´è naturalmente il Novecento: la sociologia
guglielmina (Simmel, Weber, Sombart), c´è la teologia negativa di
Karl Barth, c´è lo storicismo di Dilthey, riecheggiano perfino L´anima
e le forme e Storia e coscienza di classe di Lukács.
Ma tutto questo lungo elenco di autori e di letture fatte compare
come un trasparente distillato nella sua opera. Come una stimmung,
uno stato d´animo, con la quale il filosofo avvolge la sua opera.
In Essere e tempo tutto è degno di analisi. Ma dire
"degno" non implica agli occhi di Heidegger nessuna scelta
morale, nessun giudizio etico. Il territorio sul quale egli agisce
è senza effettiva giurisdizione. Privo di reali gerarchie,
destituito di principi guida. Solo a patto di una radicale
trasformazione del tableau filosofico, è possibile riconsegnare al
pensiero la sua funzione originaria che la metafisica aveva
dimenticato.
Molte pagine di Essere e tempo hanno la forza suggestiva di
mostrarci l´uomo nella sua gettatezza. La caduta di questo ente (Heidegger
preferirà la parola "esserci" a "uomo" e parla
di deiezione), non ha nulla a che vedere con la perdita dello stato
d´innocenza, con il peccato originale, con il paradiso. Perché
questo vorrebbe dire presupporre che esista una verità e una
origine che si situino all´esterno della temporalità e del mondo
nei quali l´esserci è gettato. Invece noi, enti tra gli enti, e
tuttavia in grado di interrogarci, siamo immersi nella quotidianità,
nella chiacchiera, nella dittatura del "si". Questa
condizione opaca e inautentica non è vista da Heidegger in modo
spregiativo. È una modalità dell´esistenza.
Dopotutto anche
Platone, con il mito della caverna, aveva raccontato la condizione
inautentica e illusoria degli uomini incatenati e condannati all´apparenza
fino a quando non fossero usciti dalla caverna. Ma è questo uscire
che Heidegger mette radicalmente in discussione. L´idea che la
verità possa rappresentarsi come astrazione suprema. Che si possa
interrogare l´Essere come fosse davvero qualcosa di estraneo a noi,
è il peccato mortale della metafisica. Il suo distacco dal pensiero
originario.
Ma allora, come darsi la verità? Come evadere dall´inautentico,
dalla chiacchiera, dall´opacità? Essere e tempo non
fornirà risposte eloquenti. Qui farà la sua apparizione il termine
lichtung (Volpi lo traduce con "radura", Marini
con "chiarità") con il quale Heidegger ci suggerisce che
la verità non va cercata (come invece accade nel mito della
caverna), perché la verità non è rappresentabile. Essa si può
solo esperire nella lichtung, quando essa ci viene incontro. Si dirà:
ma come è possibile per un esserci incatenato all´inautentico
aprirsi alla radura luminosa? La seconda parte di Essere e tempo
esplorerà i temi dell´angoscia - distinta dalla paura - e della
cura, attraverso i quali l´uomo potrà divincolarsi dalla
condizione di opacità in cui vive.
L´esistenzialismo,
in particolare quello francese, ha cercato di far proprio questo
impianto. Heidegger che lo riteneva insufficiente, demolì gli
equivoci con cui soprattutto Sartre aveva fondato la sua filosofia.
Ma in questo modo bruciava anche Essere e tempo?
C´è una
questione politica con cui si può abbozzare una risposta. È nota l´adesione
di Heidegger al nazismo. In genere la si è letta come la
riprovevole sottomissione a un tiranno senza eguali nella storia. Il
che può anche essere. Ma chi apra Essere e tempo vedrà
che parte dell´analitica esistenziale è una sorta di
attraversamento della politica. Siamo esseri gettati. Ma in quanto
enti il nostro movimento va verso la politica. Quale politica? Per
Heidegger la sola possibile e in grado di rompere con gli schemi
della rappresentanza era quella incarnata nel destino di un popolo.
Che quel destino prendesse sei anni dopo la forma del nazismo è
fortemente deprecabile e non sarà senza conseguenze per il
filosofo. Ma il punto è anche un altro.
Essere e tempo è un movimento a fari spenti verso gli
orrori destinali del Novecento. Un secolo che ha cercato l´autentico
e l´uomo nuovo e li ha grottescamente trovati nelle grandi
esperienze totalitarie. Tali esperienze sono solo il nostro passato?
L´idea che una politica, impolitica, possa ancora immaginare quel
destino, quella comunità, quella piazza, è un residuo che continua
a vivere nel lessico delle nostre emozioni. Come una minaccia
sopravvive nelle vesti risorgenti dell´uomo del destino che si fa
voce del popolo, decisione, volontà generale, corpo (magari
mediatico) di una nazione in cerca di identità. Lo snodo
inquietante di Essere e tempo è nel passaggio enigmatico
dall´inautentico all´autentico. Passaggio rischioso E non è detto
che un Dio ci farà da ponte.
La Repubblica, 29 maggio 2006, p.45